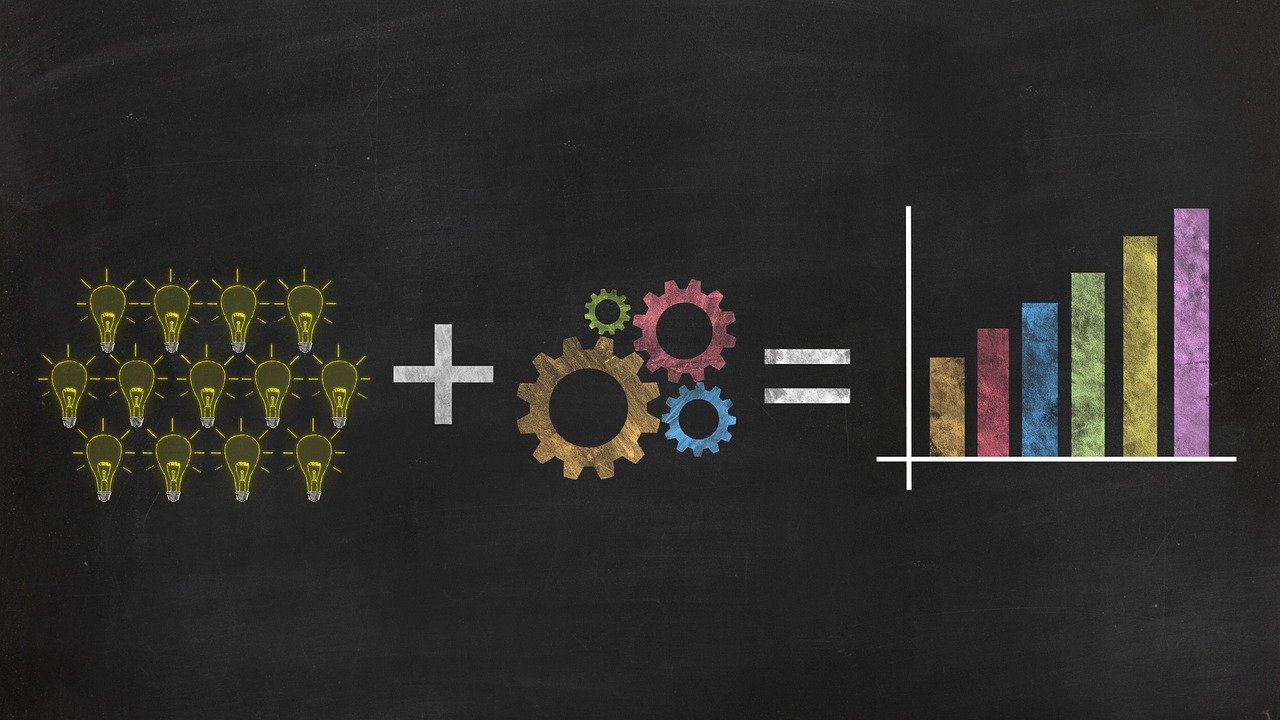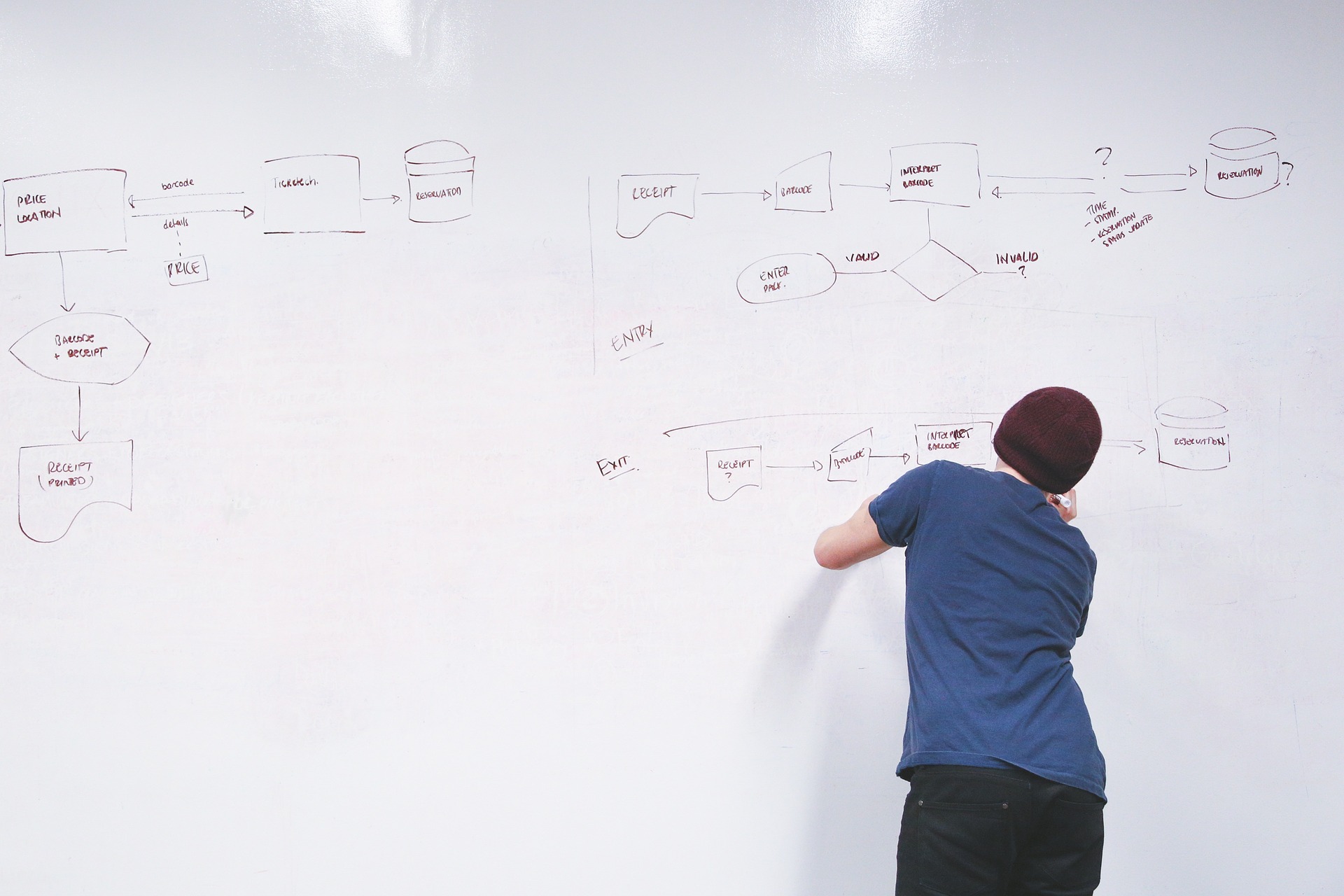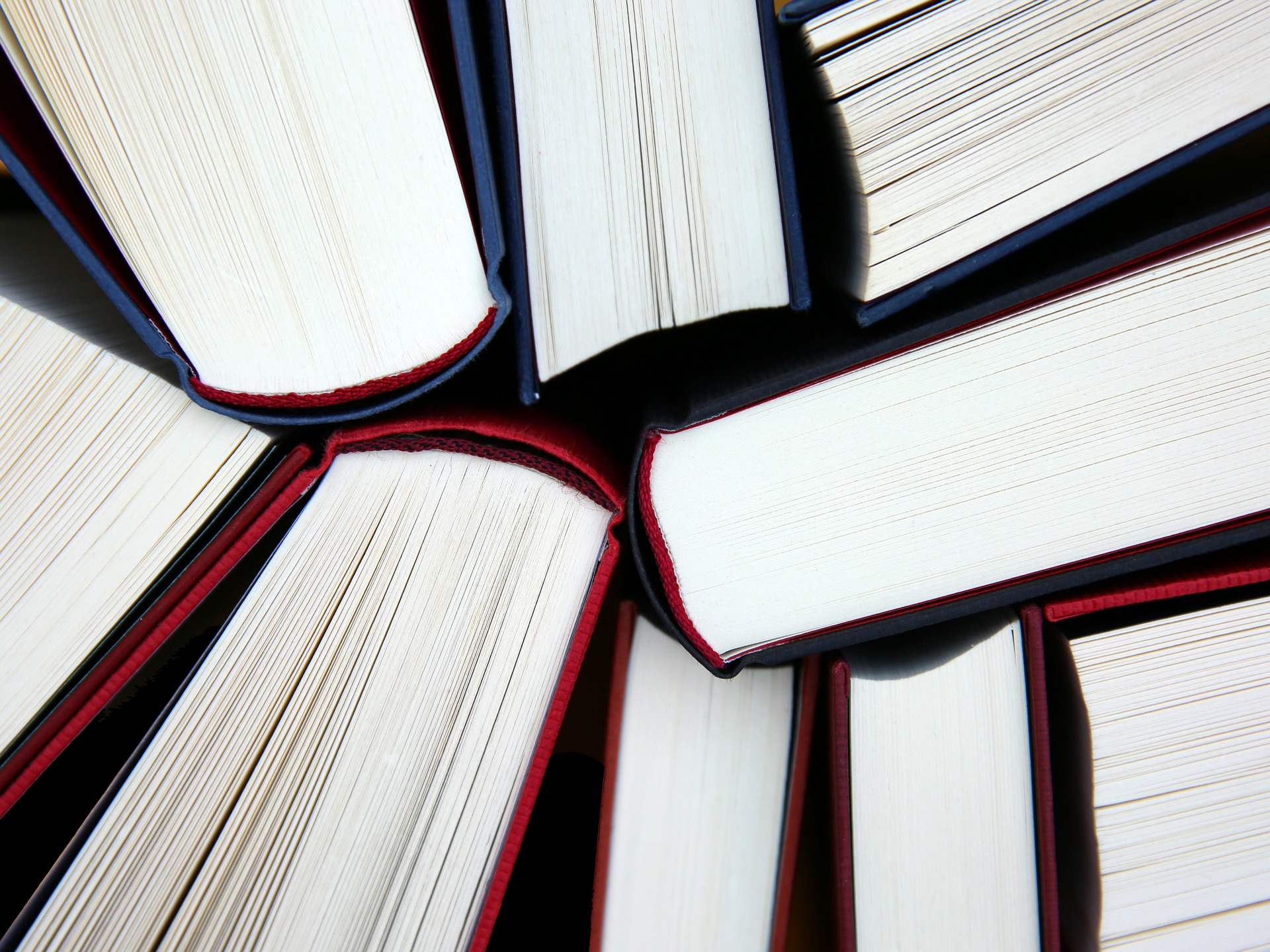L’estensione del catalogo dei reati presupposto di illecito a carico delle persone giuridiche a settori dotati di particolare tecnicismo, quale quello ambientale o della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha alimentato il dibattito sulle norme tecniche e sulla loro possibile interazione con i modelli organizzativi di prevenzione dei reati.
L’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato “Reati ambientali“, prevede l’elenco dei reati presupposto in relazione alla commissione dei quali è prevista la responsabilità dell’ente. I reati ambientali presentano diverse peculiarità se confrontati con gli altri reati presupposto.
In particolare, si tratta in gran parte di reati:
- cd. di condotta, consistenti in violazioni formali o comunque connesse ad adempimenti di natura amministrativa;
- spesso previsti da norme penali in bianco;
- costruiti sul modello del reato di pericolo astratto;
- di natura prevalentemente contravvenzionale;
- suscettibili in larga misura di essere estinti mediante oblazione;
- apparentemente comuni ma sostanzialmente propri;
- permeati da un elevato tecnicismo.
La responsabilità dell’ente per reati ambientali si configura in maniera tutto sommato contenuta. Soltanto per le fattispecie più gravi sono previste sanzioni interdittive (comunque brevi). Per le altre fattispecie, che sono la maggior parte, la sanzione è soltanto pecuniaria. Ciò determina, da un lato, una limitazione dei poteri cautelari, dall’altro, l’ampia possibilità di ricorrere al procedimento per decreto.
Numerosi sono i profili di criticità dell’art. 25 undecies rilevati dalla miglior dottrina.
Ma la problematicità della scelta legislativa che qui si intende sottolineare riguarda la mancata indicazione dei criteri minimi di implementazione dei modelli organizzativi esimenti, come invece si è verificato in occasione dell’introduzione del nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), il quale prevede altresì la presunzione di conformità legale (e dunque efficacia esimente) per i modelli di organizzazione aziendale conformi alle Linee guida UNI – INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007.
Attesa la complessità ed il tecnicismo della materia ambientale, ci si attendeva che il legislatore, sulla scia dell’esperienza dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGLS), tenesse conto delle norme tecniche e degli standards internazionali adottati dai sistemi di gestione ambientale quale punto di riferimento per le imprese ed ausilio alle stesse nella costruzione dei modelli organizzativi.
La finalità delle norme tecniche è tuttavia diversa da quella di prevenzione dei reati propria del modello organizzativo, curandosi piuttosto di garantire la soddisfazione dell’utenza, l’efficienza produttiva o l’ottimizzazione dei risultati.
Considerate tali specifiche finalità, se ne deduce che le certificazioni ottenute in base al rispetto delle norme tecniche non possono considerarsi esaustive degli oneri derivanti dall’adozione di un modello organizzativo di prevenzione dei reati.
Tuttavia i modelli di organizzazione condividono con la normazione tecnica in materia di sistemi di gestione ambientale lo stesso approccio organizzativo per “processi e procedure”, policy aziendale, pianificazione, implementazione e aggiornamento continuo. L’aspetto più significativo è però costituito dalla circostanza che la norma tecnica, codificando lo stato dell’arte in un determinato settore, potrà essere richiamata nel singolo caso concreto quale comportamento esigibile in una specifica attività.
Pertanto le norme tecniche ben si prestano ad essere utilizzate come parametri obiettivi ed esterni di valutazione in materie specialistiche sia dal giudice nel singolo caso concreto che dal legislatore in via generale ed astratta.
L’interazione tra norme tecniche e modello organizzativo si è peraltro già verificata con successo nella materia della sicurezza sul lavoro, come innanzi anticipato.
In materia ambientale, tuttavia, manca nel D. Lgs. 121/2011 una norma analoga all’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 che indichi le linee guida da adottare per uniformare i modelli di organizzazione aziendale rendendoli presuntivamente idonei a prevenire la commissione di reati ambientali, né il decreto fa riferimento alcuno alle certificazioni ambientali ISO 14001 o Emas.
Ciò nonostante, secondo le istanze provenienti dalle associazioni di categoria e le osservazioni della migliore dottrina, è verosimile che i giudici investiti di simili questioni possano fare riferimento ai sistemi di certificazione ambientale, purché adeguati a prevenire i rischi di commissione di reati, in quanto idonei a rappresentare lo standard di diligenza esigibile secondo la migliore scienza ed esperienza del momento.
Un aspetto da considerare è che i reati previsti dal legislatore ambientale (D. Lgs. 152/2006 ed altre norme settoriali) spesso vengono contestati in concorso con altre fattispecie di reato, le quali a loro volta possono rientrare tra i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001. Si pensi ai reati associativi e di criminalità organizzata, ai reati di falso, truffa aggravata ai danni della P.A., corruzione, concussione, reati informatici, disastri, danneggiamenti, riciclaggio.
Spesso, peraltro, le problematiche ambientali possono esse stesse rappresentare il presupposto per la commissione di altri reati, come nel caso di inquinamento che possa determinare un pericolo per la salute dei lavoratori o il caso di “passività ambientali” che possono costituire l’oggetto di false comunicazioni sociali.
Ciò comporta la necessità di effettuare una “mappatura dei rischi” che sia trasversale nonché di adottare, anche nella parte speciale del modello 231 dedicata ai reati ambientali, controlli (preventivi e successivi), non strettamente limitati alla gestione degli aspetti ambientali.
Il modello 231 deve quindi essere realizzato “su misura” della singola impresa, deve cioè essere “personalizzato” (nel linguaggio recente “customizzato”) per ciascuna diversa organizzazione. Ciò è ancora più necessario per la prevenzione dei reati ambientali, posto che essi vengono commessi generalmente nell’attività operativa dell’impresa con modalità eterogenee. In sostanza, occorre procedere ad una mappatura dei rischi di commissione dei reati nella quale per ciascun reato o gruppo di reati si vada ad indagare:
- quale soggetto può realizzare o contribuire a realizzare l’illecito;
- in quale processo aziendale o attività;
- quale illecito;
e conseguentemente individuare le possibili modalità attuative di prevenzione.
Ciò significa che, una volta individuati i rischi, le funzioni ed i processi sui quali intervenire, le misure da adottare:
- non solo devono essere improntate a standard ricavabili dalle fonti istituzionali, dalla normativa di settore, da linee guida di associazioni di categoria, dalle migliori pratiche ambientali (Best Environmental Practices), dalle migliori tecniche disponibili nel settore di riferimento (Best Aviable Technique, BAT), dal benchmarking (standardizzazione);
- ma devono anche essere realizzate tenendo conto della specifica realtà aziendale e delle peculiarità che la caratterizzano (customizzazione).
In altre parole, pur riconosciuta la validità e la imprescindibilità degli standards che possono essere presi a riferimento per misurare la propria organizzazione, non sembra utile l’adozione di un modello assoluto ossia efficace per tutte le realtà aziendali. Non è un caso, infatti, che l’European IPPC Bureau della Commissione europea menzioni, oltre ai sistemi di gestione ambientale conformi al regolamento EMAS o alla norma UNI EN ISO 14001, anche i sistemi di gestione ambientale “non standardised”, senza che sia attribuito a questi ultimi un valore diverso.
Non è da sottovalutare, poi, il ruolo essenzialmente creativo che ha assunto la giurisprudenza nel settore ambientale e dal quale non può prescindersi nella implementazione o nell’aggiornamento dei compliance programs per la prevenzione dei reati ambientali.
Ciò non deve indurre a pensare che l’adozione di un modello di prevenzione, soprattutto nella materia ambientale, sia sostanzialmente inutile. I vantaggi dell’adozione del modello sono comunque molteplici: oltre alla prevenzione dei reati ed alla formalizzazione delle responsabilità, va segnalata la razionalizzazione dei processi aziendali e il miglioramento dell’immagine nei confronti di stakeholders e shareholders.
Alla luce della sopra esposte considerazioni, sembra potersi concludere che un sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS, alla norma UNI EN ISO 14001 o a questi equivalente, seppur non standardizzato, costituisce sicuramente un idoneo punto di partenza nella costruzione del modello organizzativo 231 per la prevenzione dei reati ambientali. Le misure che le aziende devono adottare per evitare di incorrere in responsabilità da reato devono, infatti, essere improntate alle migliori tecniche disponibili o alle migliori pratiche ambientali e tali possono sicuramente considerarsi i sistemi di gestione ambientale.
Anche la giurisprudenza ha mostrato di apprezzare i percorsi di certificazione e l’adozione delle più avanzate tecniche di organizzazione riconoscendo alla norma tecnica la prerogativa di codificare lo stato dell’arte in un determinato settore e dunque il comportamento esigibile in una specifica attività, con immediati riflessi in tema di integrazione del precetto o di esclusione o graduazione dell’elemento soggettivo colposo.
Ciò che si rende necessario, tuttavia, è il rafforzamento di quegli elementi costitutivi del sistema di gestione ambientale che non sono in grado, di per sé soli, di soddisfare le richieste del D. Lgs. 231/2001, in un’ottica che comunque valorizzi le procedure e le prassi già esistenti in modo da evitare lo spreco di risorse e favorire l’ottimizzazione delle attività.
Può così concludersi che i sistemi di gestione ambientale determinano il progresso dei modelli organizzativi di prevenzione dei reati.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
PALUMBO STUDIO LEGALE – palumbostudiolegale.it