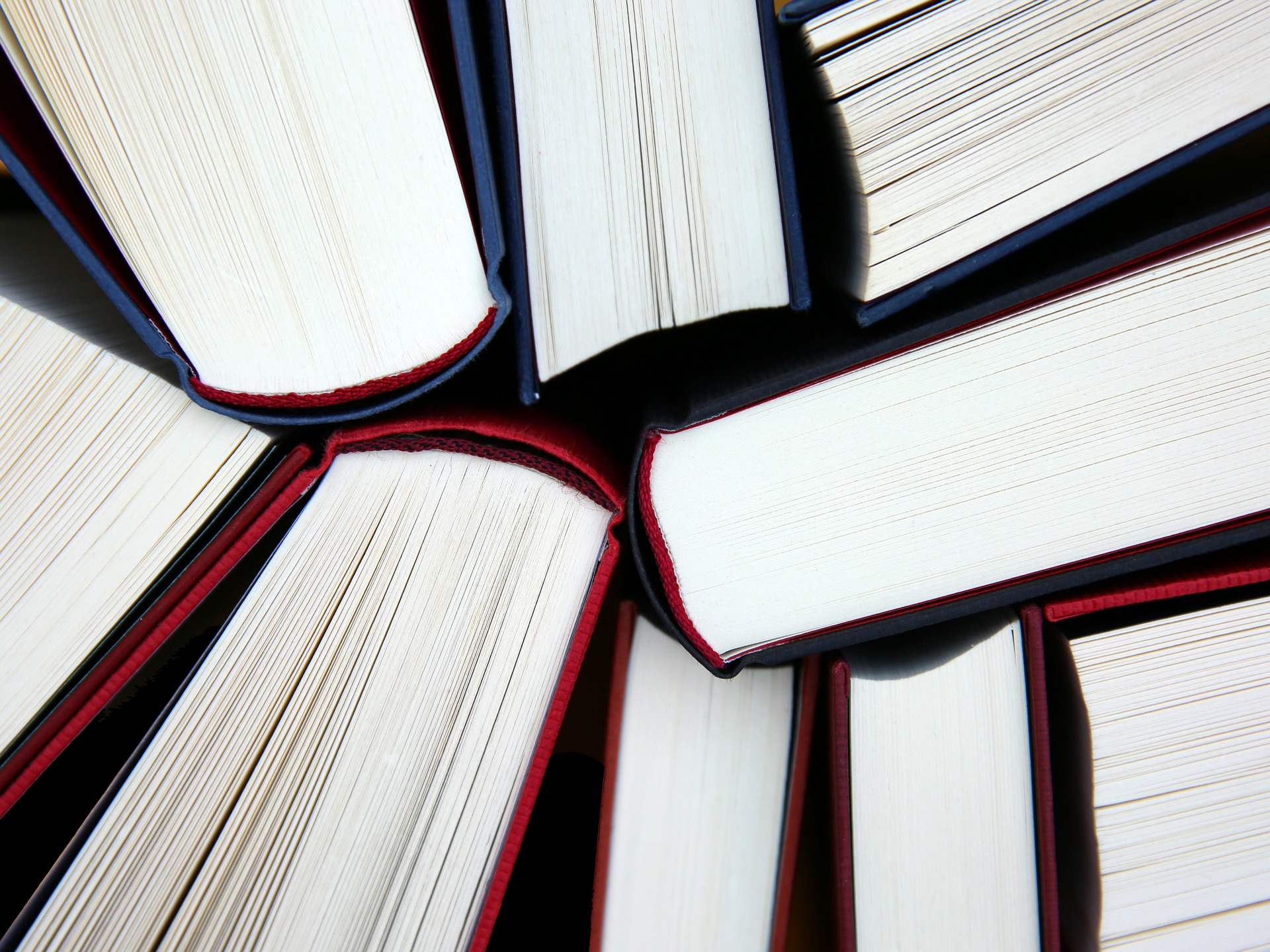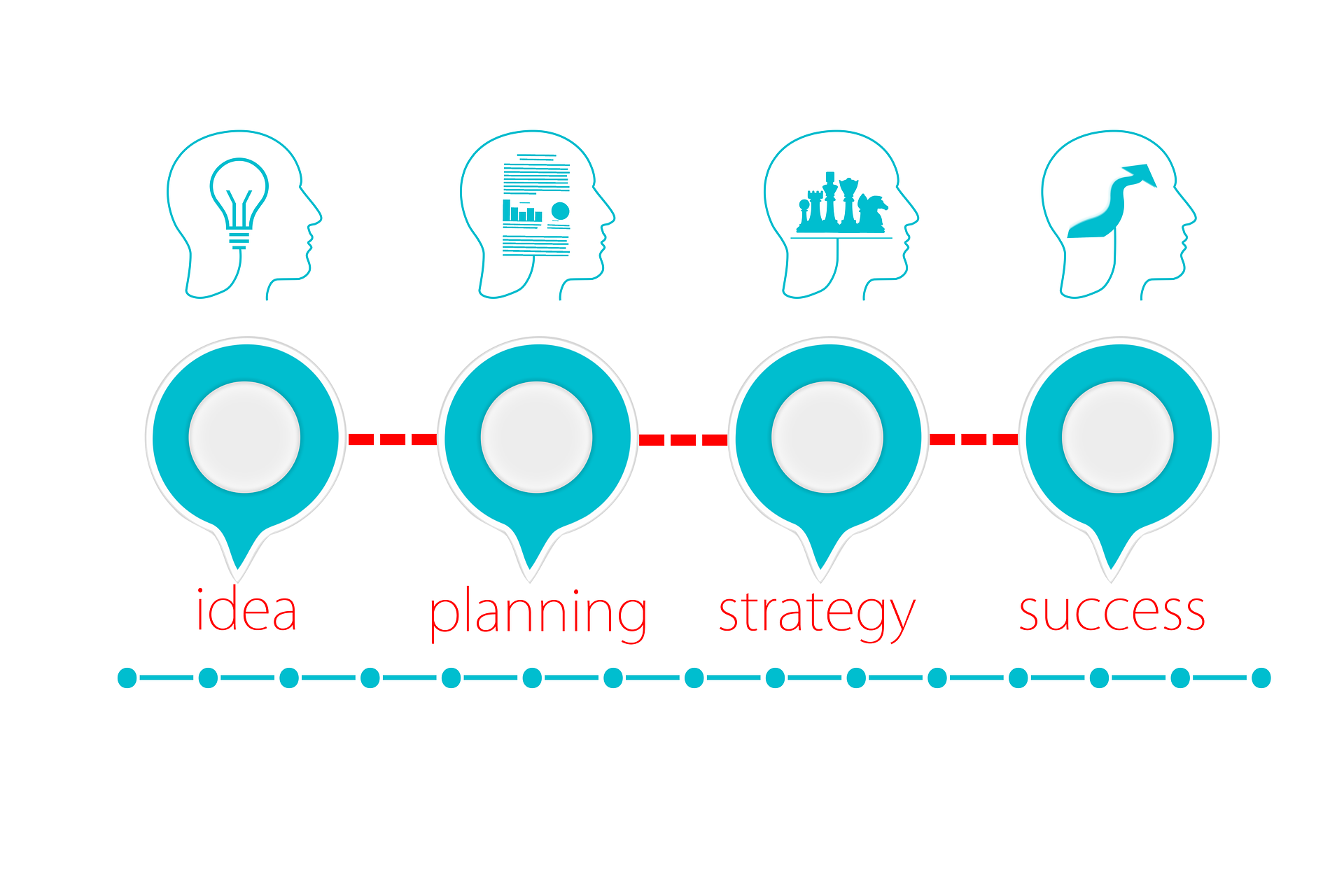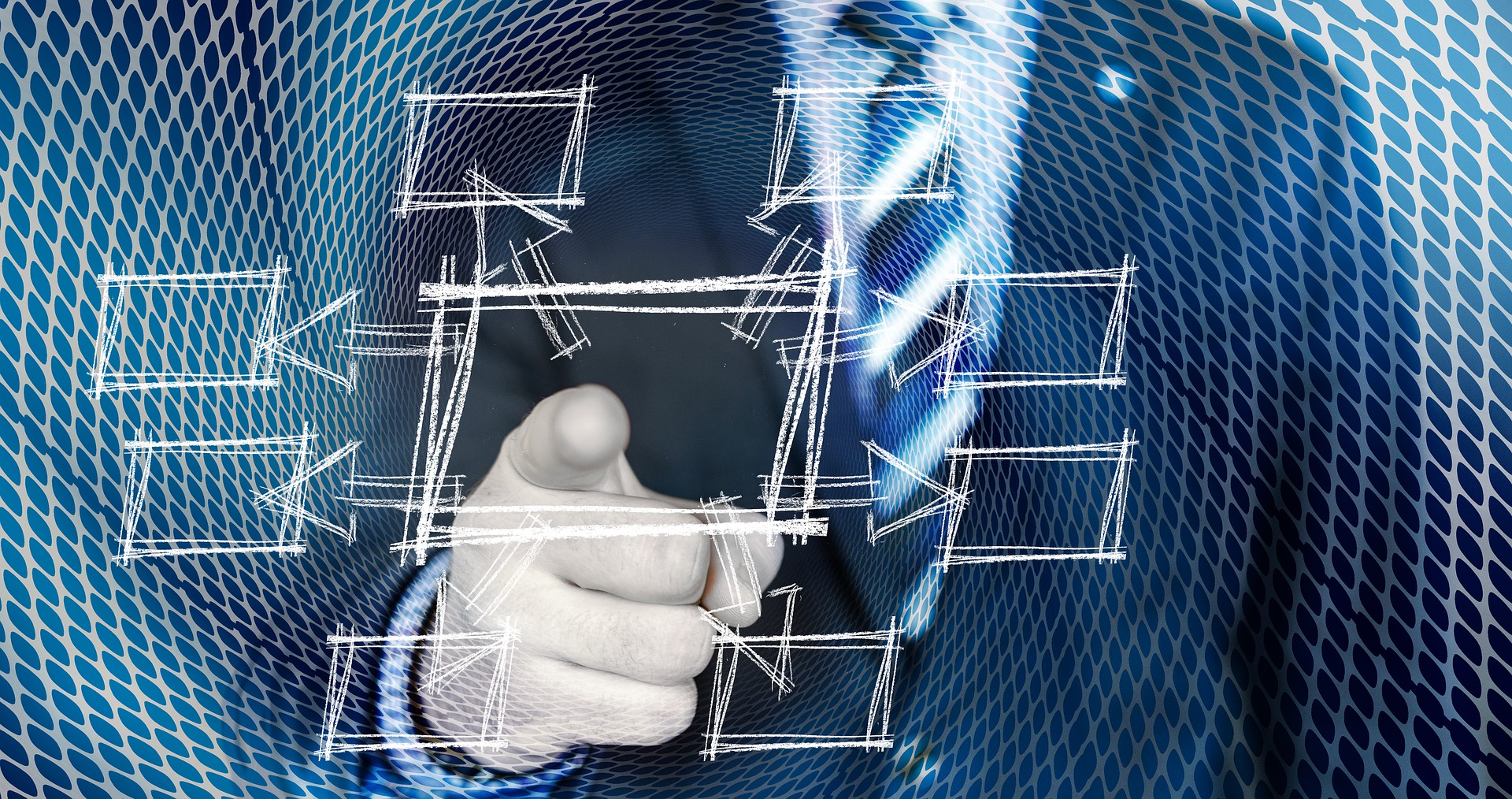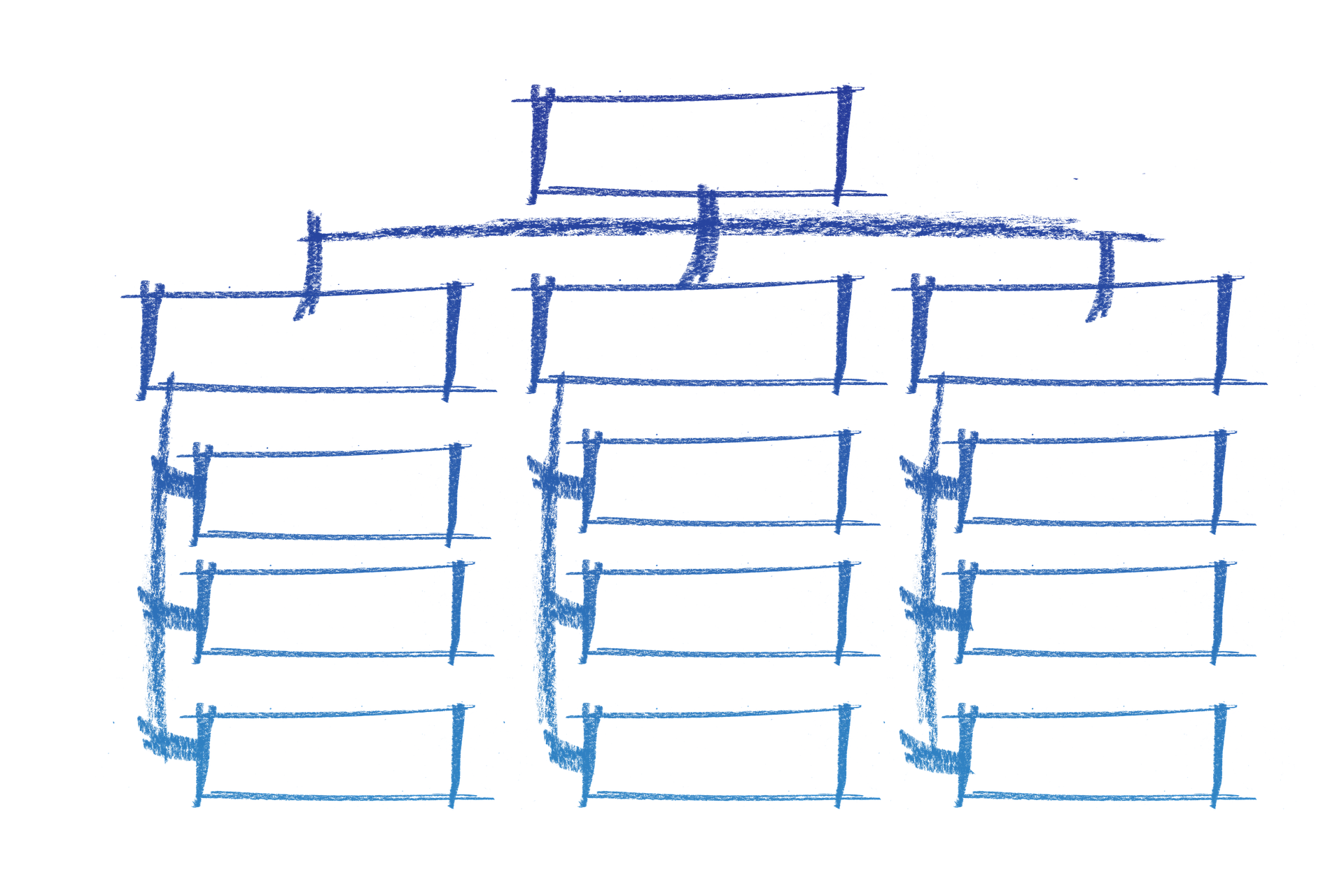Ai fini della responsabilità dell’ente è necessario non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo, ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 231/2001, ma anche che lo stesso costituisca espressione della politica aziendale o almeno derivi da una colpa di organizzazione.
Con tale ultima espressione il legislatore ha inteso indicare il rimprovero che l’ordinamento può muovere nei confronti dell’ente per non aver predisposto al proprio interno misure idonee a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti organici all’ente, siano essi organi apicali o meri sottoposti.
Struttura della colpa di organizzazione
Gli ordinamenti giuridici europei hanno elaborato una nozione di colpa di organizzazione analoga a quella caratterizzante l’actio libera in causa. In particolare, la colpevolezza dell’ente deriverebbe dall’aver consentito o agevolato le condizioni per la successiva commissione del reato.
Oltreoceano, i giuristi statunitensi hanno invece fatto riferimento alla preventive fault, ossia alla colpevolezza preventiva, evitabile mediante l’adozione di protocolli gestionali e decisionali atti a garantire comportamenti conformi alla legge. In tale prospettiva, i compliance programs fungono da criteri di commisurazione del grado di diligenza organizzativa realizzata dall’ente.
La nozione accolta dal nostro ordinamento sembra allinearsi al modello statunitense. Mentre infatti il modello europeo introduce una sorta di colpa in re ipsa (molto simile alla responsabilità civile in termini di ridistribuzione del rischio), la lettura nordamericana muove da un giudizio di rimproverabilità dell’ente collettivo per non aver provveduto ad organizzare i propri apparati in modo da contrastare le attività criminali, dimostrandosi così maggiormente rispettosa dei principi di cui all’articolo 27 della Costituzione italiana.
L’ordinamento americano, tuttavia, nell’ambito della preventive fault quantifica il grado di riprovevolezza della condotta dell’ente anche in termini di reactive corporate fault, espressione che indica un giudizio negativo formulato non prima o al momento della realizzazione della condotta, ma in un momento successivo valutando la reazione dell’ente successivamente alla realizzazione di una parte del fatto tipico. Si tratterebbe dunque di verificare quali contromisure l’ente abbia adottato per contrastare il reato nel momento immediatamente posteriore alla condotta illecita. La mancata o insufficiente reazione integrerà infatti la colpevolezza della persona giuridica.
La reactive corporate fault, o colpa di relazione come teorizzata da illustre dottrina, fonderebbe la responsabilità penale degli enti in relazione ai reati – in particolare quelli ambientali quali illeciti plurisussistenti a struttura dinamica – che per giungere a consumazione hanno bisogno della somma di una pluralità di comportamenti ripetuti nel tempo.
La teoria della colpa di relazione, pur non trovando una base giuridica nel nostro ordinamento, ben può essere impiegata come ausilio alla creazione della figura dell’ente modello.
In questi termini, i sistemi di gestione ambientale Emas e Iso 14001, basandosi proprio sul principio del miglioramento continuo, costituiscono un notevole vantaggio nella costruzione del modello di prevenzione dei reati ambientali anche in termini di reactive corporate fault.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
PALUMBO STUDIO LEGALE – palumbostudiolegale.it